|
LA PAURA
Paolo Volponi -
Poesie e Poemetti 1946-1994 - pag. 114 - Einaudi Tascabili
Agli amici
Leonetti, Pasolini, Roversi
La funivia per il
Santuario di San Luca
tutta di ferro e cruda,
oscilla al limite dei campi:
insieme con voi, amici,
m’affido al miracolo volgare
di un gruppo di gente che vola.
Ai finestrini l’Appennino sale
sopra il portico umano, fermo;
la nuvola che gira sulle valli
mi fa temere della sua pazzia.
Sappiate che ho paura di volare,
d’essere chiuso tra questa gente adulta;
ho paura del vento che non sceglie,
d’essere ancora guidato per la mano
nelle strade di passeggiate domenicali.
Sopra un vigneto ancora poco verde,
nano, bagnato di solfato,
la navicella quasi scende,
poi il declino riprende verso il paesaggio;
oltre il mio terrore che non guarda
l’occhio vede Bologna che s’arrende,
sciolta la cintura di mattoni,
alla campagna, a una monotona calura
che sbianca di caligine i confini,
che corrompe le ville,
i casolari distanti
sotto platani, tigli, ippocastani.
M’aiuta nella paura di volare
la vostra cordiale presenza, la vacanza,
la piccola valle che rompe la clausura
con il solco di terra familiare,
con la foglia del tempo corrente
nell’intreccio fresco di verdure,
nate ieri e sempre,
dove il mio occhio ritorna adolescente.
*
La paura è una casa abitata
nel grembo d’una contrada
incolta o troppo civile,
in sogno governata;
coperta di nebbia, è bianca
come una piccola noce.
Bianca non ha la luce della vita;
sempre di più si affolla
di un vivere troppo umano,
nell’ascesa di lunghe notti
che deturpano le ore
dal giorno appena composte.
Notti perenni, di luna mutilata,
con un fiato di tonfi e soprassalti,
quando i parenti serrano la casa:
essi hanno chiavi
che non fanno vedere,
hanno occhi di padre e madre
e tagli di luna tra i capelli
sino alla bocca:
desideri di cose ignote,
nemiche all’anima del figlio.
Da quale parte vanno i genitori
se lasciano sola alle pareti
l’immagine di un piccolo regnante
spaurito, che regge come un’arancia
natalizia e pronto al pianto,
l’universo e la palma?
Un’ombra ne divora la figura:
un’ombra antica li dispone nel tempo orrido di casa
che suona per l’infante lingua delle stanze.
S’aprono armadi come tombe
e luccicano fili di gioielli,
granate, rubini, coralli,
catene di parentele,
di diavoli di santi
e di tanti fratelli,
che il cuore non conosce.
Ecco dalle pareti i santi
dei romitori e deserti
in preghiera tra scheletri e leoni;
i monaci nutriti di corolle e d’insetti;
ecco gli specchi, torbida congiura,
ecco le morte spighe,
le campane di vetro dei defunti,
l’ombra dei camini,
gli uccelli dei calendari
con l’occhio di perla atterrito.
A piedi scalzi, compitando
l’anima sua e l’altrui
il più vecchio gira per la casa.
Nell’ultime stanze aperte sui balconi,
dalle ringhiere dei cattivi amori,
le donne anziane, con fiori nei bicchieri,
pettini e molti lini,
vestono da sposa
una ragazza che piange.
Presso le porte s’appoggiano i fucili
e i cani paterni alla catena
covano l’aggressione:
folle il senso animale
nega il pensiero stesso della fuga.
Allora il letto, la piccola vela del cuore
tesa tra i bianchi capi del sonno,
è l’unica salvezza; sprofondare
tra le onde delle lenzuola,
tra le sabbie del cuscino;
percorrere con la mano
le favolose strade della lettiera,
ritrovarsi nello stesso posto,
in se stesso amico,
nel centro riposto del cuore:
ecco perché star chiuso,
né prima né dopo, nel tempo dell’avvento,
lasciare la paura,
sortire per affogare.
*
Se molti sono i ragazzi
che per l’ammirazione della morte
annegano nei gorghi di fiumacci stagionali
d’acqua dispersa e stolta,
di piu ne salva la paura
del gesto intemerato,
d’arrivare con gli occhi nella folta
ombra mortale,
di trovare nel proprio l’altro volto
del quale a fianco, perenne
scorre la presenza;
la paura di un fiato prenatale.
Catturata una passera,
sia un altro uccello facile tra le siepi,
il loro stesso segreto cercano
stringendone il cuore,
o le dorate cetonie legano al filo
dei loro pensieri.
Per un segno estivo tra la polvere
o per un moto ignaro degli stagni,
bruciano le serpi d’erba o d’acqua,
che parlano d’amore con lingua innocua
e volgono lo sguardo demente
d’un demonio innocente.
Quando più alto il solleone
fa bianco ogni fiore e mortale,
con una ciga di sigaro in bocca,
il verde ramarro passionale
affida la sua morte al laccio d’avena,
alla vena del braccio
lentamente la gola alita
un dolore appagato.
Un mostro, un drago irsuto
cercano a fiore della terra,
nelle grotte intrise dei tempi:
un drago negli angoli di notte,
quando la paura batte il costato,
bianca sopra le mura e le cisterne.
Un drago che non s’arrenda,
freddo come una medaglia, un altare:
padre orribilmente nudo,
maestro ferito, ferito e colmo di sangue.
Il corpo adolescente è piagato,
numerato in tutte le sue ossa;
guarisce le ferite
incarnando la paura.
Ma vengono i compagni con maglie di cotone,
capelli forti e stinchi puri di sangue,
che portano aquiloni di luce,
nella polvere dei sandali
la virtù di un viaggio reale.
I compagni vengono a giuocare:
essi che sono veri, orfani forse,
chiamano per nome, guardano nel cuore,
e, fermi nel sole, ai sassi,
con le mani dispongono dell’ora.
I compagni che sanno nuotare:
i salvatori, che poco dopo
se ne vanno dietro il fiume
verso i covacci amorosi
o dietro gli orgogliosi messaggi
dei fuochi serali.
*
La paura è una fanciulla
che l’angelo custode e la compagna
tengono per mano.
Avesse gentile posato le sue mani
per un piccolo invito,
o mossa la veste di nastri
sul principio della mia paura;
subito avrei capito le lettere d’amore
che in me stesso l’infanzia componeva;
forse il mio cuore avrebbe attinto,
nell’incerta polvere dell’inizio,
i segni di quell’aria immatura
che allunga le membra
e dà ai giorni la magica figura
di una febbre tra cancelli e bevande.
Mi spaventava invece la sua voce
che dettava all’amica
e cadeva come una foglia;
la sua tosse educata
nell’ordine della famiglia;
la bocca bianca di raffreddore,
le labbra screpolate.
Riccioluta, forse tubercolosa nel petto,
a Pasqua del millenovecentotrentanove
i suoi quattordici anni
spandevano un odore di confetto
nelle figure del sole,
nelle regole di un giuoco sconosciuto
che legava il suo corpo
in un ordine stretto.
Io giravo intorno e non capivo
il germoglio degli occhi,
il sigillo ordito dei denti;
il gesto perfetto mi sembrava
un riprendere fiato,
sopportare una pena
a discolpa del materno peccato,
comporre una figura
a cospetto del padre.
Amare per Pasqua tale fanciulla
e non parlare; portare la mia giacca nuova
sui calzoni alla zuava,
nella tasca una sigaretta e la paura
d’incontrarla che detta,
pallida e sicura, alla compagna.
Quindici anni, sedici, diciassette,
passeggiare con i compagni sui torrioni
ventilati di primavera, verso le sette,
a quell’ora ancora caldi, d’autunno;
sentire la fatica insieme di vivere
come se nel gruppo sempre
uno fosse pronto a morire.
Guardare sorridendo le ragazzette,
anzi, le signorine, con le loro vestine
gialle, verdi e turchine
come le valli o i loro scialli
o le colline verso l’Appennino contadino.
Turchino il colore
della nostra amicizia vespertina,
con lo sbuffo della macedonia
emesso al momento dell’incontro
tra la nebbia e il sereno,
turchine le maglie sotto le giacchette,
turchino il polso della mano,
turchine le cravatte di seta.
Nel tempo incerto delle pene civili,
i baci erano come le nuvole d’un temporale
trascorso o che non viene,
sul nostro gregge di silenzio e parole.
Urgeva nelle stanze febbrili
il confine di deserti,
il volto usato da altri per le imprese:
allora si sentivano le strade, i proclami, le intenzioni;
allora la nostra camicia aperta
aveva presagi di morte.
Aspettavamo quasi d’essere altri
per l’accanita attesa di noi stessi.
*
Amare una sera estiva
al margine della comitiva,
rovinare per sempre la ragazza;
ma sentire per un momento le parole
sulla pelle se la testa è chiusa
tra le stelle della notte che pullula
sulle mura della città
e lascia una piccola luce
sulla pallida figura
che ha da un lato la veste.
Rompere il suo cuore nel palmo della mano,
farsi nemico il giorno
per non capire le giuste differenze,
ed ogni altro giorno subire
l’ansia di un altro corpo
dietro il verso nemico
del lembo rosa della veste.
Soccombere alla paura d’amare,
al terrore di dare dolore,
di rompere la cattolica
materna purezza dell’amata.
*
Quanto meglio la gravida d’affetti puttana,
fatta chiaramente di seno
sotto la maglia e poi di sottana,
sottoveste, mutanda.
Ancora calda di figli e di cibo,
ancora giovane e sorridente
tra i molti piccoli ricci,
matura di labbra e di denti,
forte piu della morte
del marito muratore.
Mi chiamava per nome
sorridendo ancora,
m’avvolgeva affettuosa sotto gli archi
o sotto le pinete,
mi baciava sulla bocca
con un sapore di noce.
La sua voce già sentivo dolce
sopra le nuvole del mio cuore:
era una voce d’amore,
innocente, di contrada,
scesa da un davanzale,
o lungo le strade e i campi,
avvertimento a un popolo che fugge
nella disfatta gioiosa del 1943.
Era una voce di contadina
che chiamava qualcuno alla vendemmia
in quell’ottobre deserto e militare;
che liberava il cuore dell’Italia
ritrovando un amore,
tra la vecchia bufera sulle case,
sugli agresti castelli e i poveri poderi.
Allora nelle stanze aperte sulle strade,
nella speranza illune della notte,
o nei giorni dispersi tra le macchie
nell’attesa di un fuoco,
sue erano le parole di fede:
chiari scioglieva gli amici dai nemici,
i vivi dai morti,
il bene dal male,
come tagliava un pane tribolato
e divideva a morsi il companatico.
Nell’amore accanito ma gentile
nei cunicoli o co vacci,
tra gli odori di lane militari,
nelle stanze affollate, quando il cielo era basso,
umano tra pioggia e fango,
tra le logge e il fumo,
nel firmamento ignudo
della sua voce,
noi trovavamo un dio felice,
vertiginoso e finito
come una ruota di fuoco.
*
Queste folle ignoranti di San Luca
sembrano di sfollati;
la collina è ferma nel suo irreale
delle alte scale del santuario.
Così erano percorsi ed abitati
i monti innocenti della guerra;
così miracolosa l’aria
dei casolari armati,
delle giornate di sole.
C’erano momenti in cui un miele
colava dalle case abbandonate:
i frutti parlavano per noi,
gli insetti nelle messi, sulle mani,
sui calzoni di noi seduti.
Lontane le piazze e i campi
e sempre di ieri o di domani
- salvo il momento quotidiano
nel cuore di chi era salvo, lontano -
dove giungeva in festa
la pazzia perfetta dei tedeschi,
quasi un fuoco artificiale
che non dovesse far male.
Trepida ai colpi di mitraglia,
come per un volo troppo affollato di uccelli,
anche la macchiola d’avellani e lecci
si riempiva di fumo tra le fronde;
piangeva da ogni foglia,
vergine di poca neve mattutina
devastata di sangue.
Di quel bosco noi altri pensavamo
piu alla terra forte,
la terra che d’inverno vuol dire
asilo e pane,
più agli alberi che d’inverno vogliono dire
vita sino a primavera,
che al mucchio umano dei morti.
Così fummo forti a vivere.
*
Vedo nel paesaggio
che non avevamo abbastanza segreti,
paesi uno dietro l’altro,
uomini tutt’insieme,
fummo espugnati cuore per cuore,
fummo resi lieti,
nei balli militari, nelle sbornie,
nelle vicende delle ladrerie.
Un esercito innocente
sciolse senza parlare
le sue bandiere d’affetto
sul geloso silenzio familiare.
Amò le nostre donne, le sorelle:
mostrò a noi stessi il verso naturale,
il lembo puro della loro veste.
Cadeva allora l’onta del peccato
e per la stessa sorte, come un fiato,
cresceva la forza del dolore.
Guardo la navicella scendere
mentre un vento sicuro sfiocca dal crinale
la nuvola, la spinge verso la terra
a vestire la caligine serale;
cosi la paura ridiscende nel mio cuore
e ricompone il giuoco diletto del male,
la libertà della contraddizione
che porta al dolore le parole.
|

QUESTA ITALIA
MariaGrazia Maiorino - Lo sguardo che si alza - Moretti e
Vitali, 2022.
Bambina in pellicciotto maculato davo la mano
all’albero grande cappotto scuro nascosta
la chioma oltre la falda del cappello
Padre trapiantato in una piazza conchiglia
con la fontana rotonda tra cedri del Libano e abeti
la tua terra è una campagna lontana
dove gli abeti si cambiano in ulivi e fichi
profumati e asini in fila riportano a gli uomini
a casa le ceste oscillanti al tramontare
Incisa nella somiglianza e ombra divisa
la tua terra è insuperata distanza
che la memoria vorrebbe riunire
cucendo insieme questa nostra Italia
che forse solo il mare saprà raccontare
con le mille voci dello spaesamento
e le montagne stregate pregate
come paradisi mai scalati
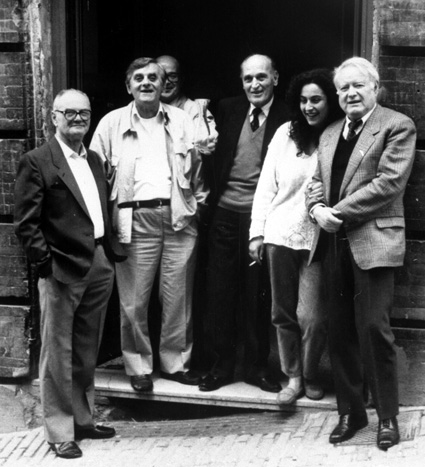
Anni 1990 all'osteria dopo la partita a carte
LA LIBERTA’ DELLA CONTRADDIZIONE
M.G. Maiorino - Lettura della poesia di Paolo
Volponi - 2012/2014 - Inedito
Comincio con una premessa e una confessione. In che modo oso accostarmi
ad autori sui quali esiste già una mole di saggi critici da incutere
soggezione e da far pensare che tutto o quasi tutto sia stato
sviscerato? Forse è la stessa molla che mi spinge a scrivere: credere
nella propria unicità e nella possibilità di partire dalla percezioni
che stratificandosi hanno formato la concrezione della propria
conchiglia. Non essere altro che un ‘common reader’, il quale ascolta
attraverso la propria conchiglia le parole di uno scrittore – un lettore
si se stesso, secondo la nota
definizione di Proust. Con il privilegio, aggiungerei, di un interesse
particolare per l’officina in cui l’opera viene forgiata, quando si
tratta di un lettore che si cimenta a sua volta con la scrittura. Perciò
ho accolto con piacere l’invito di Gastone Mosci a partecipare al
ricordo di Paolo Volponi, dedicato quest’anno alla sua poesia, seguendo
l’indicazione di partenza: poesie a specchio, quindi l’opportunità, già
prevista, di entrare in relazione con un testo in particolare. Lasciarsi
liberamente andare alle sensazioni da esso suscitate e cercare di
esprimerle attraverso un pensiero narrativo, che ricorre alle stesse
immagini del discorso poetico, quasi lo rivive a suo modo.
Ed ecco la confessione: mi dispiace molto di non aver conosciuto
personalmente Paolo Volponi, pur avendo frequentato i suoi luoghi e i
suoi amici poeti e pur avendo seguito fedelmente dagli anni ’80 in poi
incontri e letture di poesie, soprattutto in Ancona e dintorni. Come mai
ho scoperto il Volponi poeta solo nel libro a cura di Emanuele Zinato,
Poesie 1946 – 1994, pubblicato da Einaudi dopo la morte dell’autore?
Lascio aperta la domanda.
La parte del libro sulla quale sono più volte ritornata, sempre con
l’entusiasmo e la curiosità della prima volta, è quella delle prime
raccolte, Il giro dei debitori, Il ramarro, L’antica moneta, Le porte
dell’Appennino. Lì ho sentito subito echeggiare risonanze che mi
ricordavano autori come Saba, Bertolucci, Pavese, Pasolini, ma anche
Whitman, Williams e altri amati poeti americani. Ho visto i paesaggi
marchigiani aprirsi alla meraviglia, a un senso panico e sacrale della
vita, a un canto che non teme di dispiegarsi con franca e insolita
esuberanza, con adesione fraterna alle creature, fino all’incipit
francescano di Cugina volpe.
Ho scelto il testo da commentare nel mazzo di queste sezioni che non
costituiscono nemmeno un terzo del libro e comprendono un arco di tempo
che va dal 1946 al 1959. Mi sono portata quasi al confine di quelle
porte dell’Appennino, che segnano forse il concludersi di una visione
del mondo, in cui anche l’inquietudine e il male possono rientrare nella
“libertà della contraddizione /che porta al dolore le parole”, e non c’è
abiura per il ritmo naturale, per il vento che misteriosamente ci spinge
e ci piega a un destino più grande di noi. Del poemetto intitolato La
paura, dedicato agli amici Leonetti, Pasolini, Roversi, ho
ritagliato le ultime due strofe (che vi leggo).
Il poeta guarda dall’alto di un luogo sacro, la collina di San Luca,
dove è salito con la navicella della funivia, il viatico dell’amicizia
invocato a vincere la paura del volo. Il gioco delle associazioni da
lassù si fa ampio e segna il ritorno alla terra marchigiana, al tempo
della guerra e, in particolare, della lotta partigiana e della
liberazione; ma come mantenendo un filo teso con la situazione presente,
che è anche un filo di ritmo e immagini che scaturiscono dai suoni
stessi e dal disporsi delle parole. Così vediamo le folle ignoranti di
San Luca trasformarsi in sfollati, i monti resi innocenti dalla guerra,
l’aria miracolosa dei casolari armati, il miele che cola dalle case
abbandonate, la natura tutta parlante e amica. La natura piangente e
sanguinante. Ma nel momento in cui bisognava resistere vista e pensata
come terra forte, come alberi che tornano a rifiorire nel ciclo eterno
delle stagioni, e possono diventare per noi bandiere di vita e di forza.
Così fummo forti a vivere, conclude la penultima strofa.
L’ultima è tutta segnata a margine nel mio libro, letta e riletta, e
ascoltata nel suo ritmo epico, battente, fiducioso. Vi tornano parole
come cuore innocente affetto insieme naturale e puro: la guerra che
porta distruzione e morte è la stessa che rimescola le carte, che
costringe a nuove consapevolezze, che insegna nuove maniere di amare,
che ispira il verso naturale, al quale ben presto il poeta rinuncerà.
Come rinuncerà
al mito del paesaggio che attraverso di esso aveva fatto vivere. La
stessa cosa farà Pasolini snaturando le sue più belle poesie, quelle
della prima raccolta in dialetto friulano. Ma qui siamo ancora in un
bilico, in un vento che spira dall’alto e verso l’alto. E’ ancora
possibile accettare l’antinomia, la coesistenza del bene e del male,
come qualcosa di inscindibile. “La libertà della contraddizione / che
porta al dolore le parole”, dice Volponi. E nello stesso tempo,
aggiungo, ne fa strumento di riscatto, lacrima che rischiara lo sguardo,
luogo di incanto e di eterno ritorno. E un altro poeta mi viene incontro
dalle pagine de Gli orti marchigiani, Franco Matacotta, evocato
da una simile atmosfera in cui suono e senso si fanno eco, toccando
corde profonde di desideri e mancanze “ Qui noi ci chiamiamo a un cenno
/ del capo. Siamo bruschi, freddi, soli /come le gocciole. Ma umili,
caldi, / enormi come la pioggia”.
Poesia civile più tormentata e inquieta quella di Volponi, che affonda
nella psicologia, soprattutto nel suo lato oscuro: è infatti il
sentimento della paura a mettere in moto tutto il racconto, facendo da
contrappunto ai valori dell’amicizia e della solidarietà. Un’armonia
dissonante, che la forza della poesia non basta a reggere; egli sta per
esordire come narratore, la sua navicella sarà quella dell’ideologia, un
“comunista lirico” lo definisce Pasolini, e due cuori continueranno a
fremere e a lottare senza pace nel petto dell’uomo che fin dall’inizio
sentiva come fosse difficile vivere con due fiumi, con due voci, con due
sere, pur in un paesaggio apparentemente sereno e idealizzato.
La scelta di una poesia da dedicare a Volponi è venuta spontanea, non
poteva essere che un testo sul quale lavoravo da tempo, tra ricerca del
padre e spaesamento, e dove per la prima volta sono riuscita a scrivere
la parola Italia nel titolo. La patria in luogo del padre, o forse come
una più ampia paternità, propria nel momento in cui la sentivo così
ferita e fragile. Invasa da mille paure.
MGM

Anni 1990 partita a scopone
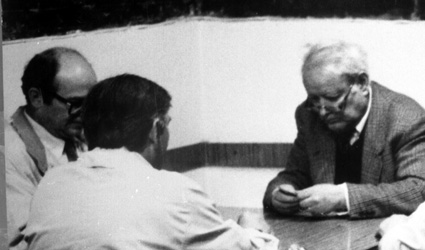
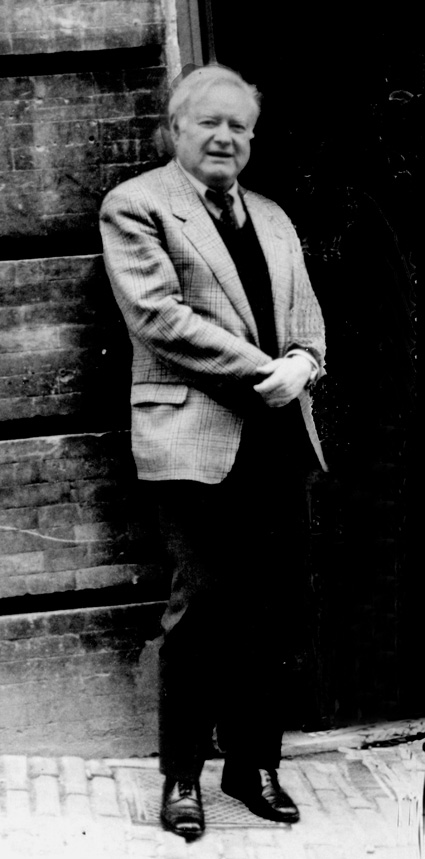
|