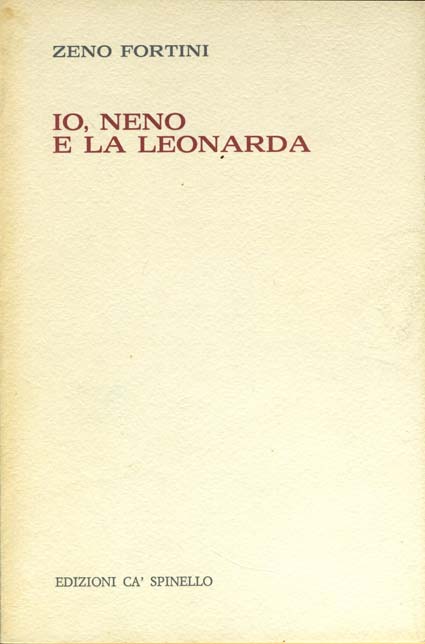|
Con due illustrazioni di Walter Piacesi
|
Il mondo dei grandi visto con gli occhi del bambino PRESENTAZIONE di Floriano De Santi
Raccogliendo in Io, Neno e la Leonarda le liriche degli ultimi tre-quattro anni, Zeno Fortini ha provveduto anche alla rifusione di quella che finora era la sua opera maggiore, Paura di dire («Quaderni di Ad Libitum», 1968), con una fitta e significativa serie di legamenti, scambi, transizioni tra i due libri, che d’altronde non nascondono aderenze con un’altra raccolta prodotta in questi anni, La ripresa (Edizioni del Paniere, 1980). In entrambe le epoche cade quella vena azzurra di flou, in cui la tenerezza della voce definisce il valore prima ancora di timbro che di significato: una grazia velata e a tratti incerta, una sorta di insicurezza struggente da cantore crepuscolare, che è proprio l’inflessione di tutta la poesia di Fortini, anche quando il tono diventa leggermente arso, trafilato in filagrane di economia essenziale. Chi abbia seguito Fortini da molti anni, sa benissimo che gran parte della sua opera è una catena di suggestioni, di inviti e riprese, di attese e di ritorni. C’è nel disegno stesso del suo lavoro una trama ben evidente di cronaca stimolante, di diario atipico fortemente anaforico o ripetitivo, diretto a riconvocare scene e frammenti. Intanto, la figura del repechage memoriale può funzionare da polarità, rispetto alla quale cominciano ad organizzarsi i corpuscoli del discorso poetico, con un processo di occultamento che vale un’ammissione. E l’idea di margine, linea confinaria, di trapasso mai completamente definito, ha molto a che fare con quel tratto caratteristico che fa della poesia fortiniana il luogo del desiderare e dell'estinguersi e rende le tanti voci cumulate variamente nel corso dell’opera (si potrebbe parlare di scrittura a più strati, polifonica) alla fine ciò che sono: teneri, strazianti e insieme profondi annunzi di solitudine. Composta nel giro di pochi anni, Io, Neno e la Leonarda è una singolare raccolta di poesie. Contiene confessioni liriche ed epigrammi, piccoli e grandi avvenimenti (la famiglia, il fascismo, la Resistenza, i compagni di scuola, le prime delusioni sentimentali), pensieri vaganti, beffe, scherni, atroci dolori. Talvolta assomiglia al diario dimenticato da un infelice in un angolo della sua stanza; talvolta ad una antologia di inni, abbozzati e abbandonati da un ignoto poeta, che ha preteso invano di cogliere gli ultimi segreti dell’universo. Eppure, chi consideri ancora Fortini come uno scrittore separato dal resto della società e della storia, difeso da maschere intellettuali una più elegante e fittizia dell’altra, dovrà finalmente ricredersi. Se una volta non ci mostrava mai il suo volto, ora ce lo appalesa in modo quasi ossessivo, come se fosse dominato da un puro istinto di sopravvivenza che lo costringe a ripetere continuamente il suo nome: «Ho sentito le urla dalla strada./ Giocavo a guardia e ladri/ con Neno, Severino e gli altri del paese./ Sono entrato e per far ridere Neno/ ho chiesto: «Nonna, quando muori?/ «Presto!» ha urlato lei/ con le mani nei capelli. La mamma era in ginocchio/ e scuoteva la testa singhiozzando,/ la zia teneva la testa nel grembo della nonna./ Io ci son rimasto male, però non lo sapevo./ Lo zio è stato preso dai fascisti/ mentre andava a caricare la legna per il forno./ L’uccideranno domattina/ al sorgere del sole/ . . .». A una lettura superficiale questa raccolta sembrerebbe ricominciare ogni volta la medesima situazione: riprende e sistema una successione di momenti biografici, di meditazioni, di referti di memoria, di visioni genericamente riferibili al patrimonio di un tradizionale «io lirico». Al contrario ciò che ne rappresenta l’aspetto più autentico e attraente è la serie degli spostamenti minimali che la percorrono da cima a fondo: «Hanno fatto anche una festa da ballo,/ ed alla fine della serata/ ci sarebbe stato un bel mazzo di fiori/ per l’ufficiale che «era bello più del nonno/ quand’era giovane», diceva la mamma/ e ripetevano tutte le altre donne./ Alla sala portarono anche me/ e Nino dei Blasoni/ fece scalmanate tutti dal pista pista/ col suo organetto con le righe d’oro./ Poi ci fu l’omaggio del paese./ Una bambina si avvicinò alle sedie in prima fila/ ed era così piccola che il mazzo di fiori/ che aveva in braccio la copriva./ I pezzi grossi del comando/ guardavano il suo vestito bianco/ che dietro spazzava il pavimento./ «E cosa fa qui la Leonarda?», ho detto/ pieno d’invidia./ «Vedi quant’è bella?» ha risposto la mamma./ «È lei che a nome del paese/ Premia gli americani/ che ci hanno liberato»/ ...». Nel brano succitato ascolta, piuttosto che un’invenzione, una produzione, intendendo con ciò che il riferimento vada non solo a un controllo naturale e stretto dell’effusione, ma a un lavoro ormai lungo di elaborazione e trasformazione che ha agito sulla materia immediatamente autobiografica. Ed è proprio l’eco mentale di quel lavoro che genera la campata melodica di Io, Neno e la Leonarda. Ma «campata» è termine troppo forte e architettonico, per indicare la linea sinuosa, insieme indugiante e netta, articolata con tanta felicità narrativa, da «Più in alto c’è la ringhiera/ che sembra un terrazzo/ attaccato al cielo/ e lì noi bambini/ prendiamo il sole d’estate,/ senza dir nulla alle nostre mamme./ Siamo così in alto/ che i rondinotti quasi li acchiappi con le mani,/ ...», tanto per fare un esempio, a «Domani partirò per il collegio./ Noi siamo poveri/ e allora mio padre ha pensato/ che in collegio/ non mi mancherà nulla./ È tanto tempo che briga/ con la Post Bellica]/ E la Post Bellica/ infine m’ha trovato il posto», ad usi verbali che sembrerebbero dedotti dall’ermetismo. Ma non è così, perché basta un’attenzione appena più profonda per rendersi conto che si tratta invece di poesia che aspira al recupero del tempo attraverso i sentimenti, i segni e i cicli che lo hanno determinato. Fortini non si abbandona mai alla vertigine delle analogie, quella vertigine che drogava spesso la scrittura ermetica; ha studiato Pascoli e Gozzano e da loro ha probabilmente imparato a farsi raccontare scaglie di vita dagli oggetti comuni. E tuttavia, la sua voce si stempera in qualcosa di diverso, che sembra offrirsi alla chiosa psicologica ad ogni punto: «Il babbo non tornerà presto. Il babbo è lontano./ Hanno detto alla mamma/ che tarderà molto./ Dopo l’attentato a Togliatti/ l’hanno chiamato per dargli istruzioni./ E sono istruzioni lunghe/ e io non potrò più mangiare/ i passerotti conditi col vino». Anche dove il paesaggio si gremisce di personaggi e di ricordi («La celere ha fatto la carica/ e ha ferito alla testa Meschini,/ il compagno di partito di mio padre./ Lui era in piazza a protestare/ perché non gli han dato il passaporto/ per andare in Belgio nelle miniere»), il discorso più ampio si apre a momenti impressionistici. È come il filo che regge le perle; le unisce e insieme consente di distinguerle per spessori e iridescenze. Il discorso è, comunque, il filo dell’intimità, del colloquio interiore. Quasi il poeta ammette il lettore nel processo di formazione delle immagini che lo impressionano e lo fanno riflettere, a partire da nessi slegati, resi per ellissi, fino a un finale equilibrato più di contenuti che di stile e sintassi. Dietro le frasi piegate e distorte di Io, Neno e la Leonardo, si avverte un disperato bisogno di espressione: una foga lutulenta e quasi informe, una furia verbale che non mai demordono il freno. Come si potrebbe lasciare la penna se tanto dolore resta non detto? Fortini riprende a scrivere, torna a riaprire le proprie ferite, commenta se stesso con sempre nuovi impeti e da sempre nuove angolazioni: al modo del grafomane, sul quale ogni pagina bianca, ogni pezzo di carta esercitano un fascino illimitato. Forse solo così — egli pensa —, forse solo variando, ripetendo, insistendo, qualche debole traccia dell’infinito potrà albeggiare in quelle parole affaticate, nelle quali emerge il senso non di una o altra immagine, ma bensì la verità dell’evento poetico. Floriano De Santi
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||