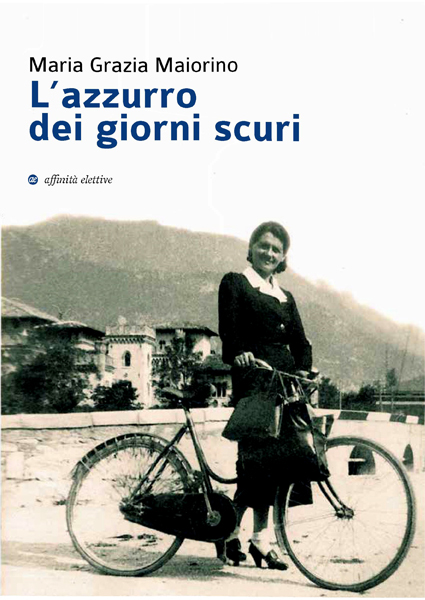|
Affinità Elettive Edizioni, 2018 |
Da risvolto di prima copertina
Chiara sta dimenticando il suo passato. Dove sono le chiavi di casa, dove gli occhiali? A mandare nell'oblio gesti abituali, luoghi e nomi è l'Alzheimer. Ma un nome lo ricorderà sempre: quello di Tiziana, sua figlia, la quale registra tutto nei suoi diari. Per lei la scrittura diventa una necessità e un conforto. L'arrivo delle badanti polacche, la decisione sofferta del ricovero in una casa di riposo, il presente che si sgretola, le ore regolate dai rigidi schemi imposti dalle istituzioni, le gioie e i dolori di una vita intera; ma anche incontri casuali, richiami della natura, libri, coincidenze e sogni... Esiste in questa storia un'aria lieve tra le parole, stranamente leggere, che raggiungono una pienezza singolare, un volo pieno di grazia e discrezione verso il mondo altrui: Tiziana si pone in ascolto, senza altri confini che la fiducia in una serena corrispondenza. L'azzurro dei giorni scuri è una lunga lettera d'amore alla madre ritrovata; un'esperienza intensa, umanissima, continuamente sfiorata dal mistero. Consigliato da: Federazione Alzheimer Italia, Associazione Goffredo De Banfield, Biblioteche della Provincia di Reggio Emilia. È inserito nella bibliografia di medicinanarrativa.eu e in P. Taccani, M. Giorgetti (a cura di), Lavoro di cura e automutuo aiuto. Gruppi per caregiver di anziani non autosufficienti, Franco Angeli, 2010.
Quarta di copertina «Più che la storia del decorso fatale di una malattia devastante e inesorabile, il libro finisce per essere il diario di una esperienza di ascolto, la registrazione misurata e profonda dell'incontro di una coscienza con il mistero di ogni alterità e l'assunzione di responsabilità che ne deriva». Antonio Luccarini, Il Messaggero «Scritti come il suo, oltre ai meriti della scrittura (agile, intensa, asciutta), contribuiscono a sfatare i molti pregiudizi che avvolgono il tempo ultimo della vita». Duccio Demetrio «L'Autrice cerca di difendere strenuamente sua madre e se stessa quando la malattia e l'incomprensione la minacciano. La sua via d'uscita, la ricerca di una salvezza personale, passa attraverso la cura affettuosa alla madre, la riconoscenza a chi le sta vicino e, non ultimo, il ricorso alla scrittura». Pietro Vigorelli «Messaggio in filigrana di umanesimo cristiano, lettura importante che coinvolge e commuove perché le protagoniste, con autentica presenza di spirito, insieme a chi le aiuta, animano quella "società stretta", avrebbe detto Leopardi, dove l'attenzione accogliente di sé e dell'altro, la confidenza, l'amicizia, esistono davvero». Germana Duca Ruggeri, l'immaginazione «E così è, noi tutti lettori amiamo Chiara. La sentiamo vicina. Come Isabel Attende è vicina alla sua Paula morente così Tiziana è vicina a Chiara. (...) È la stessa sorte a legare la Attende e Maria Grazia. Sono questi due romanzi fortemente autobiografici e pieni d'amore. Dove possiamo trovare una via crucis che le due donne vivono. Una per la figlia, una per la madre». Serena Dal Borgo
|
|
|
|
|
Presentazione del Dott. Pietro Vigorelli www.formalzheimer.it/il-presidente/ “Questo libro è un’opera d’invenzione”. Dietro questo pudico paravento si svela un libro autobiografico in cui l’Autrice, figlia di una malata Alzheimer, ripercorre fedelmente la propria vita e quella della mamma, Chiara, durante i suoi quattro anni di malattia. Vengono descritti gli accadimenti, ma soprattutto i sentimenti che li accompagnano. La Maiorino è un’osservatrice attenta e profonda e sa descrivere ogni evento riuscendo a farcelo partecipare. Scrive in modo personale e insieme avvincente, con un suo stile essenziale in cui il discorso diretto si integra con quello del ricordo, senza punteggiatura, in modo da rendere le parole più penetranti. Anche se sono tante le persone-personaggi incontrate nel corso degli anni e tratteggiate nello svolgersi del racconto, quello che emerge è un senso di solitudine della figlia di fronte alla fatica dell’assistenza alla madre. La sensibilità dell’Autrice è spesso ferita dall’indifferenza e dall’inefficienza dei medici e del personale curante. Solo qualcuno si salva: il dottor De Luca, Marisa che l’assisterà fino alla fine, l’educatrice Francesca, il dottore della rianimazione con gli occhi di chirghiso. L’Autrice cerca di difendere strenuamente sua madre e se stessa quando la malattia e l’incomprensione la minacciano. La sua via d’uscita, la ricerca di una salvezza personale, passa attraverso la cura affettuosa alla madre, la riconoscenza a chi le sta vicino e, non ultimo, il ricorso alla scrittura: “Ti prometto, Chiaretta, che racconterò la tua storia, che tu vivrai nel nostro ricordo, che altre persone ti conosceranno e ti vorranno bene”. “Continuerò a riempire pagine bianche. Saranno loro a farmi
compagnia. Oggi penso che non si dovrebbero lasciare le persone in
mezzo a un vuoto così grande, non è giusto, però non ho voglia di
chiedere aiuto”. Dott. Pietro Vigorelli |
| Inizio Pagina |
Presentazione Dott. Pietro Vigorelli |
Testi scelti |
|
TESTI SCELTI
PRELUDIO
Il preludio dell’album è un coro. Il coro è la famiglia patriarcale del “Signor da Losego”. Così era chiamato Vittorio, il nonno di Chiara. Egli abitò per tutta la vita nella casa che si trova al centro del paese, dove la fece costruire suo padre Giacinto. Un edificio di due piani, l’intonaco color giallo spento ravvivato dai profili candidi, freschi di restauro, delle finestre, della fila di oblò sottotetto, delle lesene ai lati del portone sormontato da una mensola che porta inciso il nome Giacinto. Uno spazio silenzioso, quando non è tempo di villeggiatura e le imposte rimangono chiuse, separa l’edificio principale dalle costruzioni aggiunte: le stalle sul retro, il cortile davanti delimitato dai muretti di sasso e dall’unico forno del paese, dove i contadini portavano a cuocere il pane, lasciando come obolo un “panét”. Di fianco, sul lato opposto alla strada, si apre l’arco d’ingresso della “tiéda”, il ricovero del biroccio, che nonno e bisnonno usavano per andare a Belluno. Nonno Vittorio e nonna Marietta avevano tredici figli. La foto è stata scattata in occasione delle nozze d’oro. Venticinque novembre 1939.1 bambini formano la prima fila, seduti a terra, chi vergognoso, chi spavaldo, calzettoni, cappotti, mani che si appoggiano alle gambe unite o incrociate. I più grandi accennano un sorriso. Gli adulti, tutti in piedi, seri, con le spalle ben diritte, i cappelli, gli abiti della festa, formano la seconda fila; la terza fila si fa largo tra le teste, spuntano timidamente volti femminili e spicca fra le donne la sagoma imponente della mamma di Chiara. Né Chiara né la cugina Lina sono nella foto. La coppia dei vecchi è in mezzo a due sacerdoti. Solo loro quattro sono seduti, al centro del gruppo. Nonno Vittorio ha i baffi bianchi e tiene in mano la bagolina di canna. Nonna Marietta ha il fazzoletto nero in testa, legato sulla nuca secondo l’usanza delle contadine; l’espressione energica, grave, è resa più accigliata dalle rughe. Chiara mi raccontava orgogliosa che il nonno Vittorio era per tutti un’autorità: ci si rivolgeva a lui perfino per raccomandare le anime quando il prete non poteva recarsi al capezzale dei malati. La fotografia è un monumento dell’Italia contadina. Ha la stessa compostezza del paesaggio che aleggia invisibile sullo sfondo. Punto d’arrivo di quasi mezzo secolo di storia, una guerra mondiale, le campagne coloniali, il fascismo, le malattie, la miseria, l’emigrazione quando la terra non bastava. Fissa un traguardo e un bilico, prima dello sfaldamento. Palco- scenico al quale gli attori si affacciano tutti quanti insieme e, dopo, lo spettacolo non sarà mai più lo stesso.
ORECCHINI AZZURRI
Una foto di donne che mi fa pensare agli studi leonardeschi della Madonna con Sant’Anna. Chiara è in piedi, appoggiata al tronco di un albero, una mano alla tracolla, elegante nel tailleur verde militare, i capelli biondi ondulati, lo sguardo distante. Le altre, sedute sull’erba, fanno gruppo a sé. La nonna vestita di scuro, le gambe allungate, il viso serio, l’atteggiamento protettivo verso la bambinetta seduta vicino a lei, tutta presa a scrutare un fiorellino tenuto fra le mani, il ciuffo di capelli neri fuori della cuffia, i pantaloncini corti. La bambola di pannolenci vestita di rosa, la Tina, è lì seduta anche lei, a completare questa maternità senza abbracci. La figlia è nel cuore della scena, ma è la madre ad attirare su di sé gli occhi di chi guarda: alta e svettante in un suo cielo, come l’albero dalla chioma nascosta. Questa fotografia Chiara la teneva in camera sua. Ora è diventata la foto più cara, dove riconoscere ogni volta qualcuno come fosse sempre la prima volta. Guarda – mi dice – la mamma! Il suo punto fisso, la figura più importante, inconfondibile. Nell’immagine di se stessa certe volte vede me, che ho l’età di sua madre allora. Tu eri così piccola… Dal gesto che fa con il pollice e l’indice Chiara sembra credere di aver avuto realmente una figlia piccola come quella della foto. Desiderio? Incapacità ormai di distinguere la realtà dalla sua rappresentazione?
8 maggio 1994 L’album delle fotografie. La memoria trova appigli antichi, sicuri: ai visi vengono associati nomi che non si pronunciavano da tempo, i luoghi sono riconosciuti, familiari anche se l’ultimo ritorno risale a diversi anni fa. Nomi e luoghi ancora capaci di dare vita a frammenti di storie, che formano la trama della propria. Non è l’anamnesi chiesta dai medici, nudo susseguirsi di morti e malattie che la memoria non è più in grado di sostenere, e cancella, dando l’impressione di cancellare ogni cosa. Sono i tasselli dei quali ha bisogno il sentimento di sé, per consolarsi di essere stato diverso, per ricordare giovinezza, maternità, bellezza, genitori, amori, città. Quando completo una frase, un proverbio, aggiungendo la parte mancante, con la stessa intonazione, con un vezzeggiativo, una parola in dialetto, mi sembra di dare l’imbeccata a un uccellino; divento una parte insostituibile della sua lotta per esserci, nonostante tutto. Il lessico familiare come pagina. La pagina rimasta vuota in ospedale. Non ti sentire abbandonata. Quando ti senti abbandonata pensa che ci sono io ad aiutarti. Ma quando non mi ricordo più niente come faccio a non sentirmi abbandonata? È possibile dimenticare di poter contare su un figlio, perdersi completamente andando alla deriva anche dagli affetti. Tocco che cosa significa lo smarrimento. In chiesa. Non ci ero mai stata insieme a lei. La messa è una cosa certa: i punti fermi delle preghiere, dei canti, delle risposte, la scansione regolare dei vari momenti. Sentirsi uguali agli altri. La voce esce sicura, le parole sono dette insieme, ma con la prontezza di chi le sa e non si limita a seguire. La mano cerca le monete nel borsellino per l’offerta. La mano stringe quella del vicino nel gesto della pace. L’ospedale può far impazzire di dolore con la sua indifferenza verso l’individuo. La prima difesa è dimenticare. Fuggire. Ritrovare la casa. Le strade. La chiesa.
12 maggio 1994 In ospedale. La novità del luogo cancellata. Intravisti appena i vicini di letto o additati come nemici: le hanno rubato qualcosa di suo, la stringono d’assedio, durante la notte fanno cose terribili. Accuse. Stupore. Rabbia. La casa invocata come ritorno alla normalità. Come il cibo, i piccoli riti quotidiani, le facce della gente conosciuta, il proprio nome sentito pronunciare in un saluto. Dolcemente. C’è una vecchia, di fronte a lei, consumata. Non mangia quasi più, quando le spostano l’orario della cena a causa delle trasfusioni, protesta vivacemente non per il cibo, ma per il disguido. Gli animali non amano i cambiamenti. Gli animali vanno a nascondersi per morire. Nella stanza d’ospedale ci sono occhi dappertutto, ti scrutano, non ti lasciano in pace. Aghi ti pungono. Cannule e tubicini ti imprigionano. La tua identità cambia appena entri. O sei il malato o sei il parente. Comunque un 14 15 subordinato, uno che deve agire con cautela, adattarsi al ritmo di leggi sconosciute. Nemmeno l’aria che respiri assomiglia più alla solita aria. È malata, prigioniera come ogni altra cosa lì dentro. sasét giaz gusèla ciodo cavéi tola cesa tosàt tosatèl campedèl pare mare mazaról pan picenìn sántol parón cótola ciácola caréga morósa géscol pèrsego osèi prà… Ho cominciato a scrivere file di parole in dialetto bellunese, ho riascoltato scrivendole il suono, le ho trasformate nei loro diminutivi, vezzeggiativi. Madre si dice mare. È come se lo scoprissi oggi. Mi sono “staccata” di nuovo da lei e solo da questa posizione mi accorgo di quanto sia stata coinvolgente questa brevissima malattia. Il suo corpo così lontano, sempre coperto da strati di lane. Irraggiungibile. Sfuggito. La malattia rimescola le carte, costringe a fare gesti di solito rimandati: spalmare la crema sulla pelle inaridita delle gambe, pulire le unghie con il limone, ungere con il Reparil i lividi lasciati dagli aghi della flebo sulle mani e sulle braccia, toccare il rilievo delle vene. Ricordare, afferrare ancora le forme di un corpo che non ha dimenticato la sua bellezza. Quali sono oggi le cure date a quel corpo? Luccicanti orecchini a clip di bigiotteria, grandi, rotondi, acquamarina e metallo dorato. Piccole ancore alle quali attaccarsi per uscire. Lo stesso azzurrino dell’ombretto dato sulle palpebre, sfumato o sbavato intorno agli occhi, con tocco non più esperto. Ma rimangono il gesto e l’azzurro, il colore che ha sempre accompagnato il biondo dei capelli e il chiaro degli occhi. Il suo colore. Il vestito d’angora pervinca. Gliel’ho lavato e restituito un po’ malvolentieri perché è ormai sciupato e da smettere. Lei l’ha preso come un bambino stringe a sé il suo péluche ritrovato. Nessun abito nuovo avrà il potere del vestito-péluche. Esso appartiene alla vita, quella di prima. Ha una storia, l’abbiamo comprato a… ti ricordi? La storia a volte la completo io, le spese venivano fatte quasi sempre insieme, non abbiamo mai avuto così tante cose da dimenticarne la provenienza. Una sciarpetta di viscosa a fiori, un fiocco stretto intorno al collo, un basco di morbido feltro celeste, il cappotto bianco. Siamo arrivati alle porte dell’estate e lei non osa togliersi il suo guscio. Mi chiedo se ce la farà ancora una volta. Il suo corpo di nuovo lontano, incapace di farsi accarezzare dal sole. Io sto bene con la gente! L’uscita del mattino, da sola, per andare a fare la spesa. È la guerra quotidiana per le poche cose indispensabili, il cui acquisto scandisce il ritmo di ogni giornata. Eliminati a poco a poco cibi da cucinare, fiori a cui cambiare l’acqua, panni da lavare e stirare, vetri da far tornare trasparenti, tendine da rinfrescare. Perduto l’interesse, neanche l’occhio sembra più vedere. La vista è perfetta ma non si posa, come l’udito. Ci sente benissimo, ma ascolta sempre meno. Parlare parlare. Ciacole. Continuerebbe a farlo, giorno e notte. La fatica più grande nello starle vicino è questo filo continuo: ti avvolge, ti avvolge e non ti lascerebbe più spazio se non ti sottraessi a lei. Mi chiedo se ci sia un legame con Belluno, con un mondo di donne soprattutto, fatto di un continuo ciacolare insieme. Ripenso a mia madre e alla zia Lina, quando io ero piccola e trascorrevo la mia infanzia con le loro ciacole come sottofondo. L’incontro casuale con una persona raccontato con il massimo di gioia e di durata possibile. Quasi ne sono gelosa. Io rappresento l’abitudine. L’estraneo è il “di più”. L’ incontro può riempire la giornata, essere raccontato tante volte, moltiplicandolo. È l’illusione della normalità, per cui affronta il rischio quotidiano di vivere sola.
1 giugno 1994 La fantasia della sua morte ogni volta che c’è un disguido, ogni volta che non risponde al telefono o lo lascia fuori posto. Noi due non abbiamo mai parlato seriamente della morte. Qualche battuta scherzosa, mettetemi a Pietralacroce perché a Tavernelle c’è troppa gente, anche il dottor De Luca dice così! Un proverbio bellunese, di quelli che rispuntano puntuali nelle varie occasioni: un conto l’è parlar de morte e un conto morir. La morte è stata sempre rimossa, come la vita nei suoi aspetti più “forti”, non so, la sessualità, la nascita, il dolore fisico. Penso al racconto sul parto in casa della zia, a Potenza, che nel mio ricordo infantile ha al centro lo svenimento di Chiara e il suo bisogno di cure da parte della levatrice. O alla reazione avuta quando, nella casa di campagna dove ero andata a vivere con Giulio dopo la separazione, le mostrai i dieci cuccioli appena nati del pastore tedesco Cina, e lei disse che le facevano impressione, mentre per me erano la cosa più bella del mondo. Eppure mia madre, a differenza di me, ha fatto nascere e visto morire… Non sopporto il pensiero che possa morire da sola, senza ricevere aiuto né da me né da nessun altro. Questa notte ho sognato che vedevo insieme al mio compagno (era poi Giulio?) una vecchia foto, grande come una diapositiva proiettata sull’intera parete, con l’effetto di una scena vera, dove io abbracciavo e baciavo ardentemente mia madre al mare, in mezzo all’acqua. Lui era colpito, incredulo, io scherzando ho pronunciato la parola incestuoso e l’ho abbracciato per rassicurarlo che ero tutta per lui. La foto sprizzava gioia, passione, estate, acqua, calore, insolite cose nelle mie scene familiari. Infatti subito dopo lei era a letto malata in casa di una zia e io cercavo rose da portare a tutte e due. Ricordo di aver vissuto la sua prima grave malattia, dieci anni fa, come lo spezzarsi di un ritmo dentro di me. Il dolore aumentava al momento di addormentarmi, diventando insopportabile. Mia madre dormiva da noi, che abitavamo in un appartamento ammobiliato dopo la stagione felice della campagna. Giulio la sera suonava la chitarra e ci cantava Buonanotte fiorellino. Quella canzone è per sempre legata alla sua capacità di lenire, come se raccogliesse in sé antiche ninnananne dimenticate. Il canto oggi è uno dei pochi momenti di serenità insieme. Mia madre ritrova uno sprazzo della sua vivacità di un tempo, soprattutto quando canta la Canzone del Piave: ogni volta le fa rivivere un’emozione che la rianima tutta, e si trasmette a chi è con lei. La sua è un’interpretazione accorata, assomiglia a un ritorno. Anche la memoria ritorna, le parole, la melodia, l’espressione del viso, e un lampo negli occhi come quando riusciva ancora a raccontarmi: da noi a Belun Al Piave se ’l cantea in césa. Ora il canto riesce ad arrivare dove non arrivano le semplici parole. Il mio repertorio alla tastiera è limitato, ma sono soddisfatta di strimpellare qualche canzone.Chiara continua a ripetere che sono stonata come lei e parteggia apertamente per Giulio. Se non ci sono le “sue” canzoni, se non c’è lei al centro, si distrae, prende un giornale, lo sfoglia, torna alla carica con le solite domande, insomma finisce il momento magico, il nostro tentativo di musicoterapia.
DALLA PARTE DEL MARE
Un angelo biondo in tailleur nero attillato passa per le vie del paese. È il giorno della visita di De Gasperi. Primi anni cinquanta. Non so chi le scattò quella foto, da cui si dipana con fatica il filo dei ricordi. Il sud continuamente rimosso, come una sconfitta. Una mancanza. Lei ci arrivò la prima volta attraversando con mezzi di fortuna l’Italia distrutta dalla guerra. Macchia rossofiamma e biondochiaro nel nero del sud. Subito fuori luogo, troppo diversa dalle donne del paese per essere accettata. Subito forestiera. Cerco di immaginare come potevano apparire ai suoi occhi le strade dove passavano maiali legati da una cordicella, asini carichi di ceste, i cavalli con i pennacchi delle carrozzelle non ancora sostituite dall’unico autobus, che faceva servizio dalla stazione al centro del paese. Dove donne dai lunghi scialli scuri camminavano diritte tenendo in testa sul cercine giare di terracotta e grandi panelle fatte in casa e portate a cuocere al forno. Trecce puntate intorno alla testa, unte d’olio, rifatte di tanto in tanto fra comari del vicinato. Madri che spidocchiavano i figli sulla soglia di casa. Pomodori stesi al sole sui marciapiedi, fichi aperti a seccare, nugoli di mosche dappertutto. Il nonno grande invalido di guerra, il palazzo rivestito di pietra, gli scalpellini che battevano, la rivincita sulla miseria dei bassi, dove uomini e bestie dormivano insieme. I nostri mobili accatastati nella camera da letto, i vasi di gerani subito rubati, il pane bianco, la luce troppo fioca, mio padre che faceva il pendolare e tornava il pomeriggio da Potenza, il circolo, gli amici, le nostre ore vuote. La casa-rifugio era quella di zia Dina, la moglie veronese di un fratello di mio nonno, anche lui ritornato invalido dal fronte. Camminava aiutandosi con due bastoni e portava un cappello con il paraorecchie estate e inverno. Si scendeva dal corso, la grande cucina si affacciava direttamente sulla scalinata, c’era sempre qualcuno in visita. La zia aveva mantenuto l’accento veneto, la vedevo accudire il marito, sempre premurosa e servizievole come una brava infermiera. Una specie di santa. Senza età.
Gruppo di donne in primo piano sedute intorno a un tavolino rotondo, metallico, come le sedie con finta impagliatura di plastica. Di mio padre e mio zio, sullo sfondo, si vedono solo le teste, e di un altro uomo, lateralmente, una mano che tiene una sigaretta. Anche tre delle donne stanno fumando, la sigaretta fra le dita o le labbra, lo sguardo rivolto verso l’obiettivo. Si assomigliano. Sono nella sala del circolo cittadino, indossano gonne longuette abbinate a maglie appena scollate o abiti interi guarniti con larghe sciarpe di lana, lavorate all’uncinetto, appoggiate sulle spalle. Le bocche disegnate dal rossetto, qualche accenno di sorriso, gambe accavallate, scarpe nere con il tacco alto. Scruto il viso di Chiara, cerco i suoi colori nel bianco e nero della fotografia: la sua espressione mi sembra triste, forse tutte sono prigioniere di un loro mondo separato, ritagliato in interni, cure domestiche, visite con bambini al seguito, chiacchiere, complicità, segreti, e in mezzo silenzio, come qui, sospeso, immobile. Quali erano i pensieri di mia madre quella sera di carnevale, quando aveva trentaquattro anni e io otto, e tutto assomigliava così poco a quello che avevamo lasciato? I caffè in piazza, i tavolini all’aperto, e la musica d’estate, le sale da tè rivestite di legno con caminetti e quadri, ma soprattutto gli appuntamenti quotidiani all’ora dell’aperitivo e a metà pomeriggio. A Belluno amici e amiche, conoscenti, magari era solo una battuta scherzosa, un saluto, un darsi appuntamento per un’altra occasione, ma nel mio ricordo c’è allegria nella piazza, ci siamo noi bambini che ci rincorriamo, che ci nascondiamo sotto i portici e giochiamo a “sassetti” o a “campanòn” vicino alla grande fontana rotonda dei giardini. La piazza di Melfi, dove si affaccia il circolo, non ha tavolini all’aperto, i bar sono riservati agli uomini, che se ne stanno in piedi, dentro o fuori, a capannelli, soprattutto la sera e la domenica mattina. C’è la carrozzella ferma, e la spavalderia di fare lo “struscio” con il primo corteggiatore. Mio padre sapeva cantare. Quando intonava una canzone la sua profonda voce baritonale improvvisamente si addolciva stemperandosi nella melodia di Signorinella pallida o Piccola santa, come si sintonizzasse a sua insaputa su una stazione diversa del cuore. Se potessi riascoltarla anche solo per un attimo potrei afferrare un sicuro frammento del mio padre sconosciuto. Mi limito a registrare la sorpresa, oppure no, era lo stesso padre capace di gesti affettuosi, di una tenerezza che i genitori non avevano potuto avere per lui; di lettere d’amore spedite a Belluno, che Chiara leggeva e rileggeva commossa e grata alla lontananza. Una volta che ero a letto malata mi regalò un’enciclopedia degli animali in due grossi volumi rilegati. Non so se fu un caso, una di quelle offerte fatte negli uffici, o se era un implicito messaggio di attenzione. Ci ha messo molto tempo, ma è arrivato. Il mondo animale mi ha conquistata e mi piace pensare che sia stato anche merito suo.
6 febbraio 1996 Ora il viaggio è lungo la costa. Andando a Senigallia posso vedere il mare ogni volta, le case delle vacanze tutte chiuse, giardinetti coperti da teli di plastica, la ferrovia a ridosso della riva. La sera della vigilia, prima di addormentarmi, un’associazione mi ha attraversato la mente: il mare del sogno, fatto prima che mia madre entrasse a Villa Negri, e il mare ritrovato a Senigallia. Non lo so se è una forzatura, ma ho trovato un po’ di conforto. E le immagini di quel bellissimo sogno continuano a tornare e a sovrapporsi a quelle reali, cercando punti in cui combaciare… Questo complesso di edifici, che ha la solidità armoniosa delle costruzioni ottocentesche, si trova in mezzo alla città. Non ho più l’impressione dell’isolamento. Le strade corrono diritte, intersecandosi, fino al mare, che è vicino e si sente nell’aria. I gabbiani volano sopra le case. Camminavo lungo una passerella, un ciglio, nel sogno: mare quieto, di porto. Rose. Le suore indiane hanno pelle e capelli scuri che contrastano con l’abito bianco, semplicissimo, e grandi sorrisi. Sono giovani, sembrano aprire con la sola presenza spazi più grandi. Vorrei che Chiara riuscisse a ricevere un po’ della loro dolcezza. Anch’io vorrei riuscire a metterla fiduciosamente nelle loro mani e a sognarla in sogni tranquilli. Faccio fatica ad accettare la sua agitazione perpetua, vorrei scuoterla, vorrei spiegare, spiegare, la sgrido, mi pento. Chiara violenta che scalcia e dà schiaffi alle operatrici. Il progredire della malattia o una reazione dovuta allo spaesamento? Vieni a dormire con me? Come era lucida mentre pronunciava queste semplici parole, esplicite nella loro richiesta d’affetto, di sicurezza. Il sonno come un abisso profondo, il terrore di precipitarvi da sola. Il sonno come morire ogni notte, lontana. La fuga dal letto, unica possibilità di salvezza. Chiara nella carrozzella-seggiolone, quando sono arrivata, il secondo giorno. Il mio viso che si rabbuiava. La fretta di toglierla da lì, di portarla con me in passeggiata, “nella normalità”. Non è facile l’impatto con questa nuova casa di riposo. Il rituale dei pasti a Osimo era meno sbrigativo, l’ambiente più familiare, la cameretta di Chiara simile a una stanza di casa… Se potessimo portare ovunque la nostra casa-guscio con noi! Chissà se Chiara ce la farà, o se questo cambiamento sarà solo un ultimo trauma. Il dottore ha detto che ci vuole un mese di tempo. Un mese mi sembra un’eternità. Oggi ritornerò con Marisa. Spero la riconosca. Spero le porti un po’ d’aria di casa. Spero di non essere mai dura con mia madre. Questo diario è una lunga lettera d’amore per lei.
7 febbraio 1996 Il reparto di fronte a quello di Chiara è riservato ai semiautosufficienti. Ci siamo entrate lunedì pomeriggio, insieme alla signora Marisa, che voleva salutare una conoscente. Le finestre dell’ingresso e di uno dei corridoi si affacciano sulla cappella sottostante, come la galleria di un matroneo: la Madonna dell’altare maggiore, illuminata, è stata una visione inattesa che mi ha subito richiamato alla mente il mio sogno. Come in un processo rovesciato, un altro tassello di realtà torna indietro a comporre l’enigma? O siamo noi alla continua ricerca di simboli, di ancoraggi? A far durare la luce dorata dei nostri sogni, a scavarvi piccole nicchie, a farvi sbocciare fiori di irreale bellezza? Chiara calma, senza lamento. Lo sguardo di Suor Ammu: può stare tranquilla adesso! Mia madre è a letto, le do il bacio della buonanotte e lei sembra abbia proprio voglia di dormire. La fotografia con me e Luna sbuca da sotto il plaid, sul divano, la bambola di pezza, il cuore di cotone rosso, fatto all’uncinetto, che viene dalla Norvegia, regalo di Donatella. Nella camerata c’è silenzio. Mi allontano senza ansia. Il viaggio in corriera e i racconti di Tondelli mi aspettano. Una settimana domani. Ritorno su di mattina, venerdì, il giorno della visita dello psichiatra, che qui passa ogni quindici giorni. Finalmente. Lo aspettiamo senza allontanarci dal reparto per la passeggiata lungo i corridoi del pianterreno. È passata già l’ora in cui dovrei essere fuori per prendere la corriera delle dodici e trenta, quando esce dall’ambulatorio e si avvicina a noi insieme all’assistente sociale e alla suora. Saluta Chiara dandole la mano; le chiede come si trova e se sa dov’è. Lei inizia uno dei suoi discorsi confusi, viene fuori la parola Belluno… Io guardo Chiara, guardo lui, sono sulle spine. Vorrei dire tante cose, stabilire un contatto. Quando è stata ricoverata a Osimo, mi chiede, era rigida? Rispondo di sì, rigida in tutto il corpo e senza conoscenza. Le prende un braccio, faccia vedere. Ha mai preso il Valium? Rispondo di no. Aggiungo che a casa prendeva il Lantanon. (Volevo fargli capire che non aveva sperimentato altri psicofarmaci oltre al Lantanon e al malefico cocktail di Villa Negri, ma mi pare che lui fraintenda, infatti sottolinea che il Lantanon non serve). Il Talofen è efficace, ha detto, aggiusterò la terapia. Non è un neurolettico? credo di aver chiesto timidamente, ma non ne sono nemmeno sicura. I miei dubbi sugli effetti collaterali, compresa l’invenzione delle parole, me li tengo per me, la visita è finita, lui se ne è andato. Lascio Chiara con l’assistente sociale, che mi dice: se gli vuole parlare… Mi pare che non sia il caso, rispondo. Schizzo via per prendere la corriera delle dodici e quarantacinque. Delusione? Sì, inutile negarlo. Inutile addolcire il solito bollettino del dopopranzo a Donatella. La conclusione è che sono di nuovo alle prese con l’istituzione, sarà sempre così. Lascio Chiara in un ingranaggio, che da una parte ci permette di continuare la nostra vita prendendosi cura di lei, e dall’altra tende a fare di lei una rotella uguale alle altre. Quando torno a casa mia mi sembra di entrare in una fortezza, dove mi sento protetta: mi tengo la mia bella solitudine, il silenzio, smaltisco gradualmente ansia e fatica. Ho riletto il finale de Il grande Gatsby, mi sono lasciata commuovere da un passo sul quale i miei occhi e la mia mente avevano sorvolato, chissà perché, e ora lo sento che punge, che tocca una specie di ferita, un senso di emarginazione, che ritorna fuori più forte in questi ultimi anni, insieme alla delusione, alla paura che il futuro si accorci, non abbia braccia abbastanza lunghe per i nostri sogni e ci respinga invece verso il passato, come barche controcorrente. Ultima, tragica immagine del libro.
14 febbraio 1996 Ritorno da Chiara lunedì pomeriggio e la trovo in uno stato di grande agitazione: le spalle non sono più curve, cammina diritta e con il collo rigido, sembra indemoniata. Continua a dirmi andiamo via, si lamenta, qualcosa che è più forte di lei le impedisce di fermarsi, di posare lo sguardo, di rendersi conto di quello che le succede intorno. Non vuole mangiare, si alza dalla sedia, sono costretta a imboccarla quasi a forza, alzandomi anch’io, e cercando di difendere il suo piatto da Clara, veloce come un gatto nell’afferrare il cibo ovunque le capiti a tiro, come se fosse perennemente affamata. È molto faticoso stare vicino a Chiara in queste condizioni. L’agitazione è contagiosa. Mi informo sulla terapia prescritta dallo psichiatra: la dose degli psicofarmaci è stata aumentata e ritorna l’incubo del ricovero in ospedale di settembre. Ho paura che abbia una nuova crisi. La suora ci preannuncia la necessità di trasferirla nella stanza dove ci sono le ospiti che di notte non “stanno tranquille”. Mi sembra di aver sbagliato tutto. Invece quando ritorno a Senigallia trovo Chiara tranquilla, insieme a una signora bionda, che ha la madre con il sondino. Chiara tiene in mano la dentiera, gliela lavo e le dico di mettersela da sola. E lei lo fa. Non ci riusciva più da tanto tempo, quasi non credo ai miei occhi. Ha parole dolci per me, mi segue docilmente, si siede sul letto mangiando con piacere i pavesini che le ho portato. La suora mi dice: ha dormito, oggi va bene. Come si spiegano queste differenze di comportamento, di stati d’animo? Forse la terapia sta funzionando dopo una crisi di rigetto? O sono semplicemente gli sbalzi d’umore legati alla malattia? Anche a cena siede tranquilla, mangia volentieri, mentre Argia inventa canzoni spalancando la bocca, dove le sono rimasti solo due denti. Chiara guarda il marito di Ginevra, che si lascia mordere le mani e cerca di frenare affettuosamente i dispetti della moglie, in silenzio. Un dialogo fra loro due fatto di mani che stringono, di sguardi, parole sussurrate, gli occhi di lei persi e un po’ spaventati, quelli di lui sorridenti, comprensivi, come se dicessero: ma che cosa mi combini? Stasera posso fermarmi più a lungo, ci sediamo in sala da pranzo, dopo la cena. La televisione trasmette Okay, il prezzo è giusto, e Chiara sembra guardare, cogliendo qualcosa, mentre sbocconcella la merendina che le ho dato come dessert. Continua a essere diritta, quasi austera, Mi sembra un donchisciotte, con gli zigomi sporgenti, gli incavi delle tempie, il naso affilato. Gli occhi guardano dritti davanti a lei, non lasciandomi intuire pensieri. Scuri specchi di ciò che le accade intorno, captano e subito perdono, forse cercano il filo che si è rotto tra le percezioni e la mente. Ora è proprio immobile, seria, come tesa su un bordo sconosciuto. Mi fa venire in mente la vecchia che domina la festa di compleanno nel più bel racconto di Clarice Lispector: lei è al di là, altrove. Vorrei sciogliere mia madre, scaldarla, cantarle una ninnananna per farla dormire tranquilla. I cartelloni di carnevale appesi alle pareti del corridoio, i festoni che pendono allegri dal soffitto: domani ci saranno musica e balli.
15 febbraio 1996 Ora vado da Chiara di pomeriggio e le mattine sono tutte per me. Trascrivo i sogni appena sveglia, rileggo qualche rigo di appunti sul sogno del Mandala, raccontato da Jung nella sua autobiografia: si trovava a Liverpool e saliva dalla città buia e fuligginosa alla luce di una magnolia fiorita nell’isoletta al centro di un piccolo lago. In quella visione, della quale nessuno dei suoi compagni si accorgeva, la rappresentazione del sé. Per la prima volta mi chiedo che cosa può significare il mio sogno riferito alla totalità del sé. Rileggo… C’è il mare calmo di un porto, ci sono le rose, c’è la luce del tramonto sulle scalinate di una chiesa. C’è questo passaggio obbligato da attraversare insieme a un gruppo di anziani per uscire di nuovo nello spazio aperto, verso un autobus in partenza per Parigi. Il mio sé è l’interno di una chiesa antica, riscaldata dalla cerimonia sacra, dalle luci, dalla presenza di cibi e di suppellettili confortevoli. C’è accoglienza in questo interno. Un’accoglienza così rassicurante è raro incontrarla nella realtà. C’è anche uno strano miscuglio di sacro e profano, di compagnia e solitudine. Il mio sé come passaggio, e forse come ritorno… Quando si apre il cancello ed esco nel buio, lasciando il Santa Maria Goretti, tiro un sospiro di sollievo, come se uscissi di prigione. Sono contenta che non ci sia subito l’impatto con il traffico della città. L’isola pedonale del centro di Senigallia è un luogo ancora da esplorare, soprattutto in questa stagione. Il selciato non è liscio, obbliga a rallentare un po’, a rendersi conto dei propri passi, irregolari come i ciottoli. Comincio a riconoscere i negozi, così illuminati sembrano diversi. Non guardo in alto, ma la città mi appare tagliata a misura, in armonia con le vie strette, i palazzi, il silenzio, le persone che ti passano vicino e le noti. I lampioni lungo il corso, il bisbigliare di un passeggio discreto che ti lasci alle spalle, attraversandolo in un attimo. Ti rimane la vaga sensazione di una scia, dalla quale ti faresti portare. Poi quelle voci di gabbiani sopra la tua testa. Volano senza farsi vedere nella notte. Sono capaci di allargare infinitamente lo spazio, evocando la presenza del mare fra le case, non fanno lo stesso effetto sulla riva o in mezzo all’acqua. Vado, tenendomi stretto il mio sogno. Cammino svelta tra gli occhi delle vetrine. Ti porterò, te lo prometto, a camminare per queste strade. Resisti, Chiara, ti prego, resisti. Aiutami a partire. Aspettami qui, vicino al mare. Gocciolano le immagini del sogno in quelle reali come cera di candela calda che si rapprende in forme strane, modellate dalla fiamma. La rocca è un castelletto a guardia di questa città piatta, indifesa, ne attraversa i giardini. Oltre il muretto si arriva a prendere contatto con la realtà, passano camion, treni, proprio qui davanti alla fermata dei bus c’è la stazione. Quando i treni passano senza fermarsi la scuotono tutta come un terremoto. Sulla corriera di Bucci sono disegnate due ali bianche.
20 febbraio 1996 Chiara è nel salone, mi viene incontro, riconoscendomi, contenta come sempre, anche se subito mi parla come se avesse da raccontarmi chissà quali sevizie (dopo mi dicono che le hanno fatto il bagno e che le hanno anche tagliato un po’ i capelli). Facciamo due passi fuori, con Maria Pia, la sua assistente privata. Chiara non andava per una strada da giugno, e la cosa non sembra sconvolgerla: è tranquilla, appena un po’ intimorita dall’aria frizzante. Le spiego che siamo a Senigallia, che lei ci veniva in auto, che non lontano c’è il mare e la famosa spiaggia di velluto. In giardino salutiamo Lorenzina, che prende il sole nella sua carrozzella, accompagnata dal fratello. E un gattone bianco e nero. Risaliamo per il pranzo. Chiara adesso mangia da sola. Maria Pia l’aiuta mettendole i bocconi nel cucchiaio, e lei lo porta alla bocca con gesto sicuro. I suoi occhi guardano intorno curiosi: è attratta dal fratello di Vera, accanto a lei, continua a dire quanto è bravo. Sembra infastidita, invece, dalle maschere, e forse dall’attivismo delle animatrici. Continua a ripetere che vuole venire con me. Poi accenna al letto, forse vorrebbe riposare ma da sola non è capace di trovare un angolo tranquillo dove stendersi. Mi aiuta Francesca. La sistemiamo nell’unica poltrona allungabile, in salone, e piano piano lei si addormenta sicura della mia vicinanza. Vi ho guardato dal corridoio, appena arrivate, voi due sole con il borsone delle cose da sistemare nei cassetti, eravate di spalle, quante scene simili a questa mi hanno fatto stringere il cuore nel corso del tempo. Francesca me lo dice adesso ed è come rivedermi in una scena mancata, attraverso una pena che rimbalza da lei a me: un’estranea si stava già prendendo il mio dolore, conosceva i nostri nomi, Chiara e Tiziana. Francesca è un’educatrice del progetto Alzheimer, ha la mia età e un modo di fare aperto, vivace. La ringrazio dentro di me per i suoi braccialetti d’argento, per i pendenti con le pietre dure o le perle e i golfini allegri sotto il camice bianco. Per il tono di voce con cui pronuncia “la Chiara” con l’accento senigalliese, che rende più tonde e luminose le a e più sonante il nome di mia madre. Unisce sempre al nome un gesto affettuoso, adatto a lei, e una sospensione d’attesa per lasciare che arrivi e riceverne conferma. Qualche volta l’ho vista scrivere nel quadernone delle relazioni, a fine mattina, attaccare delle foto in bacheca, discutere con un altro animatore. Ma la maggior parte del suo lavoro, come quello degli altri, si svolge all’esclusiva presenza degli ospiti e posso solo immaginare la pazienza nel guidare le loro mani a dipingere, tagliare, ripiegare, intrecciare. Pazienza e capacità di sognare, certo, di immaginare, colmando mancanze e rispettando blocchi forse definitivi. Immaginare ugualmente colori per ogni mese del calendario da parete, con le castagne o l’albero natalizio, la maschera di carnevale, e lo scorrere delle stagioni che deve essere visto anche qui. L’odore di una stagione trasmesso da una carezza? Nessun miracolo è impossibile finché l’affettività resiste, Francesca ci crede, ognuno di loro mantiene fino alla fine la propria affettività, ognuno secondo il suo carattere. È su quella che bisogna far leva. Quando esco sono passate le due, ci sono già i bambini mascherati per il corso, che si tirano la schiuma in attesa dei carri. Prendo una brioche e un cappuccino al Caffè centrale. Cammino svelta lungo il fiume per raggiungere il capolinea delle corriere. Incrociamo una piccola banda improvvisata, la corriera si ferma per farla passare: svoltano dalla parte del mare suonando una marcetta. Qualcuno tra i viaggiatori commenta: solo loro? no, laggiù ce ne sono altri… Carnevale dappertutto e in tanti modi, carnevale in questa minibanda paesana, con i passanti che si uniscono ad essa come se andassero in processione, la voglia di ridere insieme, di radunarsi, di portare i bambini, di organizzare la festa per gli anziani, forse anche Chiara riderà. Buonanotte carnevale.
28 febbraio 1996 L’atrio è impregnato di odore di fumo e perfino il fumo, entrando, mi sembra rassicurante: un odore diverso da quello dell’abbandono… Domenica scorsa sono ritornata a Villa Negri con Giulio per prendere le ultime cose di Chiara. Siamo entrati dal cancello nuovo, abbiamo lasciato la macchina fuori, nel parcheggio, e una sensazione di isolamento mi ha gelato. Erano quei riquadri d’erba verde, perfetti, squadrati, limitati dal bianco dei bordi; era la fontana rotonda, nuova, senz’acqua, davanti alle vetrate buie dell’ingresso di una volta; era il silenzio e l’assenza di persone e di macchine all’interno, solo le luci forti di alcune file di finestre. Era, forse più di tutto, la sedimentazione di sensazioni d’abbandono provate nel tempo, ogni volta che venivo via lasciando Chiara sola nel nuovo reparto, dove stava dal mese di ottobre. E il luogo che d’estate mi era sembrato così accogliente, così diverso da come avevo immaginato fosse una casa di riposo, ora voltava faccia. Me l’aveva voltata da quando c’era stata la ristrutturazione e l’apertura della nuova ala, da quando i vecchi erano scomparsi dalla circolazione all’esterno. Da quando avevo cominciato a notare la sfasatura tra le energie e i soldi investiti in questo maquillage esteriore e la miseria all’interno, la scarsità del personale, la superficialità della direzione e dei medici. Invece qui a Senigallia c’è sempre qualcuno di guardia: l’atrio, non assomiglia alla hall asettica di un albergo, non è così bello, non ci sono piante, però ci sono loro, calmi, seduti, salutano, ognuno ha il suo posto fisso. C’è un telefono a gettoni, una grande specchiera di legno scuro, dove mi guardo, dandomi una ravviata, prima di salire. La maniglia alta, la porta a vetri pesante, il corridoio da una parte e dall’altra, soffitto a volta, scalinata di marmo quasi di fronte, ascensore a sinistra. Nel reparto di Chiara si arriva solo con l’ascensore perché le porte sono chiuse a chiave. Spesso il viaggio si fa in compagnia, ci sono sedie a rotelle o carrelli e altro, c’è sempre qualcuno da salutare. Appena si apre la portiera dell’ascensore tendo le orecchie, sperando di non sentire subito il lamento di Chiara e la cerco con gli occhi, chiedendomi come la vedrò, sarà calma o agitata, come l’avranno vestita, sarà pettinata, avrà la dentiera, mi riconoscerà?
1 marzo 1996 La signora che ha la madre con il sondino è vicino alla porta della camerata delle donne, alla quale mi affaccio con Chiara per farle vedere il posto dove mangiava prima. È bastata una domanda, quanti anni ha sua madre? È ancora giovane. Ed è seguito un torrente di parole. Scorrevano senza interruzione, io guardavo il suo viso truccato, i capelli biondi ricci e lunghi, la rivedevo vestita da principe azzurro il giorno di giovedì grasso, sembrava una ragazzina con la parrucca. La avevo immaginata molto brava a ritagliarsi nell’organizzazione familiare il tempo di tanta assiduità vicino a sua madre, perfino quello di mascherarsi, e invece stavo scoprendo il buco senza fondo di solitudine, che può lasciare l’assenza materna in una figlia di quarantatré anni incapace di una vita autonoma. Quando l’ho portata qui, una mattina di giugno, volevo andare a buttarmi sotto un treno. Una tentazione quei treni che passano velocissimi senza fermarsi, squassando la piccola stazione di Senigallia, li vedo la sera mentre aspetto la corriera, penso che il treno può diventare una specie di calamita, come il vuoto, non amo le stazioni. Nel torrente di parole vedevo una donna vacillante, spaesata, che ritrovava un mondo estraneo fuori della casa di riposo. Il suo appartamento troppo grande, poi venduto. Un’amica che la incoraggia a cercarsi una piccola pensione dove andare a vivere finché non avrà una nuova casa. L’accoglienza affettuosa nella pensione, dove si prendono cura di lei, la chiamano per mangiare, si preoccupano quando non arriva. Mia madre ha cominciato con le cadute: si è rotta prima i polsi, poi un braccio, poi una tibia. Ha cominciato a non sentirsi più sicura, a non uscire più da sola. Io ero sempre vicino a lei, la notte invece di dormire fumavo. L’ultima volta dalla parrucchiera per la tinta – lei aveva i capelli rossi quando è entrata qui – eravamo in tre: l’assistente, io e la parrucchiera a starle dietro, non ne potevo proprio più. Se non la portavo qui me la toglievano, l’assistente sociale, il giudice, stavano per fare le pratiche… Lei mi ha detto: se mi porti nella casa di riposo io non parlo e non mangio più. E così ha fatto. Hanno dovuto metterle subito il sondino per nutrirla, ma nessuno è più riuscito a farla parlare. [.............................................]
|